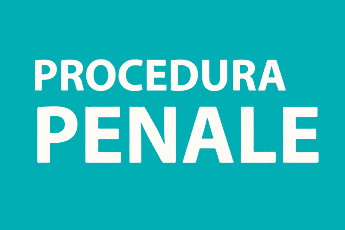
La vicenda giudiziaria da cui ha avuto origine tale pronuncia vedeva protagonista un soggetto indagato per il reato di atti persecutori, cosiddetto "stalking", per aver minacciato e molestato un altro soggetto, residente nello stesso edificio, insultandolo, anche con riferimento alle sue condizioni fisiche.
In seguito all’accaduto, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale applicava al soggetto agente la misura cautelare del divieto di avvicinamento all’edificio in cui si trovava la dimora della persona offesa, con l’obbligo di mantenersi ad una distanza di almeno 50 metri dallo stesso.
Dopo essersi visto rigettare dal Gip la richiesta di riesame, il difensore dell’indagato ricorreva in Cassazione lamentando come il Gip avesse, di fatto, applicato una misura più afflittiva di quella richiesta da Pubblico Ministero, che si era limitato a chiedere il divieto di avvicinarsi alla vittima e di parlargli. Avendo riguardo alle specificità del caso concreto, infatti, la misura cautelare disposta risultava più afflittiva di quest’ultima poiché, vivendo le parti in piani diversi dello stesso edificio, essa costringeva l’indagato a lasciare la propria casa, subendo una restrizione della propria libertà maggiore di quella richiesta dalla pubblica accusa.
Il difensore dell’indagato, nel proprio ricorso, evidenziava come, alla luce di tali circostanze, il Gip avrebbe dovuto rigettare la domanda dell’accusa e applicare una misura cautelare che escludesse il contatto tra le parti garantendo però, al tempo stesso, un contemperamento delle esigenze di entrambi i soggetti coinvolti i quali, pur vivendo nello stesso edificio, usufruivano di diverse entrate ed aree di parcheggio.
Il ricorrente eccepiva, inoltre, l’insussistenza di indizi così gravi da giustificare l’applicazione di una misura cautelare tanto afflittiva, evidenziando come l’accaduto non avesse determinato nella vittima né un mutamento delle sue abitudini di vita né uno stato d’ansia. Lo stesso difensore dell’indagato faceva, anzi, presente che, come emerso in un altro procedimento che vedeva protagonisti gli stessi soggetti con ruoli inversi, era, in realtà, la persona offesa a cercare dei pretesti per incontrare l’indagato, il quale si limitava a reagire alle provocazioni altrui.
La Suprema Corte, pur giudicando apodittica l’affermazione della difesa per cui la persona offesa non avrebbe subito stati d’ansia o cambiamenti delle proprie abitudini, considerate le concordi testimonianze acquisite durante il giudizio, ha annullato con rinvio l’ordinanza emessa dal Gip, accogliendo, così, le doglianze dell’indagato.
Secondo gli Ermellini, il Gip avrebbe semplicemente potuto ordinare all’indagato di non avvicinarsi all’abitazione della persona offesa, senza imporgli di mantenere una distanza di 50 metri che, nel caso concreto, si era tradotta di fatto in un divieto di dimora, violando, così, il fondamentale diritto dell’indagato di utilizzare la propria casa. Come osservato dai giudici di legittimità, infatti, dalla normativa in materia di misure cautelari emerge che il giudice, nell’applicarle, deve salvaguardare anche i diritti della persona che ne è destinataria. Inoltre, l’art. 282 ter del c.p.p. prevede che, qualora ad un soggetto sia precluso l’accesso ad un certo luogo, esso gli debba comunque essere garantito quando sussistono ragioni abitative o lavorative, come nel caso oggetto della pronuncia in esame.




